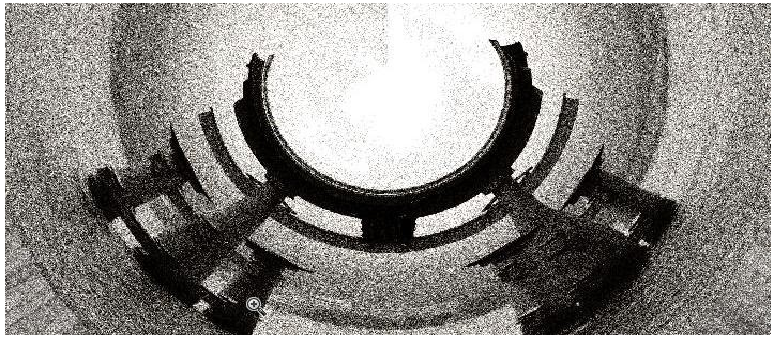"Binario 1000", racconto breve premiato presso il Salone internazionale di Torino come quarto classificato nel "Concorso letterario nazionale 88.88" promosso dall'associazione culturale YOWRAS.
«Buongiorno» dissi con
evidente imbarazzo alla donna che aveva appena aperto la porta ad uno
sconosciuto.
Tutto era cominciato un anno prima,
quando ero in attesa del treno nel paese in cui sono nato. La stazione era
straordinariamente grande in confronto alla poca affluenza di passeggeri. Ben
quattro binari correvano alternandosi a tre banchine in cemento. Poco più in
là, altre rotaie finivano in un binario cieco, in cui da bambino avevo giocato
immerso in mille avventure immaginarie. Binario mille lo chiamavamo, forse
perché c’erano già quelli dall’uno al quattro e cinque ci sembrava riduttivo.
Ricordavo benissimo i miei amici, l’erba che cresceva disordinata e meschina.
Era una domenica sera. Tornavo
a Milano dopo aver fatto visita nel fine settimana ai miei genitori che
abitavano ancora nella casa della mia infanzia. Ero solo nella stazione,
avvolto nel prematuro buio dicembrino, punto dal freddo portato dal vento.
Ero in anticipo, come al
solito. La curiosità e la nostalgia mi portarono vicino alla recinzione che
limitava il nostro binario mille.
Echi di giochi lontani stuzzicarono i miei sensi, riportando lucidi i ricordi
di odori, colori e scherzi tra amici.
Era ancora lì, come lo
ricordavo, schiavo dell’immobilismo che affligge da sempre il mio paese.
Di colpo vidi ombre muoversi
in lontananza, dietro gli ultimi pilastri dell’edificio. Passi svelti, parole
sussurrate.
Due, forse tre.
Risate, ragazzi probabilmente.
Insulti, fragore, urla.
Una richiesta di aiuto.
Il profumo della mia infanzia
fu inghiottito in un istante da una palpitante preoccupazione.
Senza esitare cominciai a
correre, con la valigia saldamente stretta nelle mani.
«Ehi voi!» Esclamai con il
fiato corto.
Pochi altri passi e mi resi
conto di quello che stava succedendo. Tre ragazzi stavano picchiando un senza
tetto che aveva cercato riparo dal rigore della notte.
Vedendomi si fermarono come
sbalorditi che qualcuno potesse davvero prendere un treno in transito in quella
stazione. Lessi nei loro volti ancora imberbi la baldanza esaurirsi nel terrore
di essere smascherati, probabilmente agli occhi dei genitori.
Uno di loro diresse insulti
nella mia direzione e sferrò un calcio al viso del malcapitato a terra prima di
correre via.
Feci letteralmente volare via
la mia valigia e cominciai ad inseguire a perdifiato il trio. Pochi metri dopo
mi ritrovai con le mani sulle ginocchia, troppo lontano da quei ragazzi che,
spinti da qualcosa che non comprenderò mai, si erano accaniti in modo aberrante
sul senza tetto.
Trovai le energie per correre
indietro e sincerarmi delle condizioni dell’uomo.
Era a terra, ricurvo e
intorpidito dal freddo. Il viso insanguinato e i cartoni che lo avrebbero
dovuto riparare sparsi intorno a lui. Respirava a fatica.
«Tutto bene?» Mi sentii idiota
nell’aver davvero pronunciato quelle parole.
Recuperai un minimo di
lucidità e chiamai un’ambulanza. Poi, mi chinai sull’uomo.
«Stanno arrivando i soccorsi.
Tieni duro. Riesci a sentirmi?»
Silenzio.
Mi vergogno ad ammetterlo, ma
esitai diversi secondi prima di poggiare la mia mano sulla sua spalla.
Feci una lieve pressione e
provai di nuovo ad interrogarlo.
Con una velocità che non avrei
in nessun modo potuto preventivare, mi afferrò la mano.
Le sue dita sudice entrarono
in contatto con le mie.
Lottai con me stesso, ma
sconfissi il mio istinto di mollare la presa.
L’uomo, al contrario, strinse
e sussurrò qualcosa.
Mi chinai, avvicinando il mio
orecchio alla sua bocca.
“Beatrice”, riuscii a cogliere
nel suo farfugliare. L’uomo, lasciò la presa e frugò in una tasca interna dalla
sua giacca logora. Estrasse un piccolo ciondolo, simile ad una moneta bucata
nel centro. Allungò la mano e fece scivolare il ninnolo nella mia, bisbigliando
di nuovo lo stesso nome.
Poi fece cadere indietro la
testa. Gli tenni la mano finché non arrivarono i soccorsi.
Persi il treno.
Rimasi sconvolto dalla notizia
della morte del senza tetto. Dopo due giorni in terapia intensiva aveva smesso
di lottare. Il suo già provato fisico non aveva retto ai colpi subiti.
Un agente di polizia a cui
avevo lasciato i miei recapiti mi disse che il nome della vittima era Vladimiro
Risi, ma tutti lo ricordavano come Didi. Non lo avevo mai visto prima, ma
sembrava che in paese fosse conosciuto. Chiusi la telefonata rigirando il
ciondolo tra le mani. Per qualche ragione, Didi aveva deciso di affidarmelo.
Trascorse un mese in cui fui
particolarmente preso dal lavoro e mi lasciai travolgere dall’affannosa routine
quotidiana. Finché non mi resi conto che non sarei stato degno di proseguire la
mia vita se non avessi onorato la memoria di Didi, come ormai mi ero abituato a
chiamarlo.
Feci delle indagini e scoprii
che in passato era stato benestante, proprietario di una piccola azienda
vinicola. Complice gli anni di crisi, gli affari avevano cominciato ad andare
male e si era ritrovato in breve in mezzo ad una strada.
Non era stato sposato, né
aveva stretti legami di parentela. Il tutto rese più difficile per me quello
che sarebbe diventato uno scopo imprescindibile nella mia esistenza:
rintracciare Beatrice.
Individuai un uomo che era
stato suo dipendente. Mi raccontò che Didi era stato un uomo generoso, capace
di dare una liquidazione premio ai suoi dipendenti quando era stato costretto a
chiudere. Non seppe però darmi alcuna informazione sulla donna che stavo
cercando. Mi comunicò tuttavia un paio di nomi di persone in qualche modo
legate a Didi.
Impiegai due mesi per scoprire
che portavano entrambi ad una pista cieca. Continuai allora a fare ricerche
sulla società di Didi, scoprendo molti dettagli, ma nessuna pista concreta che
conducesse ad una donna di nome Beatrice.
Cominciai a trascurare il mio
lavoro e fui richiamato formalmente dal mio capo. Risposi che era un periodo
difficile e che avrei preso dei giorni di ferie accumulati per ricaricarmi. Mentii
senza provare alcun disagio.
Continuai a girovagare senza
grandi risultati nei dintorni del mio paese. Le mie ferie si esaurirono troppo
in fretta e tornai a Milano. Non facevo altro che pensare alla ricerca di
Beatrice e, spesso, sognavo di notte il pestaggio di Didi al binario mille. Sei
mesi dopo presi un’aspettativa al lavoro tra le minacce velate del mio capo e
l’incredulità dei miei colleghi.
Feci delle indagini più
intense. Entrai in possesso di un’enorme mole di dati sulla vita di Didi, grazie
ad alcune amicizie che avevo nel mio paese. Cercai in ogni direzione.
Nel mio peregrinare feci
visita alla banca dove aveva avuto il conto Didi. Con mia grossa sorpresa,
riconobbi nel direttore della piccola filiale Samuele, un mio amico d’infanzia.
Lo abbracciai con affetto e un attimo dopo ci ritrovammo a ricordare i meravigliosi
momenti condivisi da bambini. Non tralasciammo, ovviamente, il mitico binario
mille.
Fu in quell’istante che gli
raccontai il motivo della mia visita. I visi sorridenti sfumarono in pochi
istanti.
Chiesi aiuto al mio amico di
vecchia data.
Non che potesse fare molto, mi
disse, ma diede comunque un’occhiata alle movimentazioni del conto di Didi e
della sua società. Stava forse violando qualche normativa sulla privacy, ma mi
spiegò che aveva notato qualcosa di particolare, un numero cospicuo di
versamenti a favore di una società di cui mi rivelò il nome, pregandomi di non
fare parola a nessuno di quanto mi aveva comunicato.
Ci lasciammo con la promessa
di rivederci presto.
Rintracciai la società e
scoprii che si trattava di una cooperativa che operava a favore di bambini in
difficoltà, per lo più orfani. Didi era un filantropo, conclusi. Valeva la pena
approfondire la faccenda.
Salii su un treno verso Lecce,
sede della cooperativa.
Alberi si alternavano a
piccoli paesi arroccati sugli Appennini. Il cielo grigio, sferzato qua e là da
dorati raggi di sole, era la cornice del turbinio dei miei pensieri
disordinati. Mi chiesi chi fosse davvero quell’uomo che aveva concluso i suoi
giorni celato dietro ad abiti logori e barba incolta.
Raggiunsi infine la porta
della cooperativa. Suonai al campanello.
«Buongiorno» dissi con
evidente imbarazzo alla donna che aveva appena aperto la porta ad uno
sconosciuto. Era una suora di nome Benedetta.
Mi invitò ad entrare e le chiesi
se conoscesse Didi o una donna di nome Beatrice. Ero pronto ad andarmene, temendo
di essere di fronte all’ennesimo vicolo cieco, quando la sorella cominciò a
parlare con voce tesa.
Mi disse che, tanti anni
prima, era stata amica inseparabile di un bambino meraviglioso. Con il passare
degli anni, l’amicizia era tramutata in sentimenti più profondi. Quel bambino
era divenuto un ragazzo incantevole dai modi gentili ed eleganti. I suoi
genitori erano però contrari a quel legame ed avevano proibito alla ragazza di
incontrare il giovane. Lei aveva disubbidito più volte per vedere il suo
Vladimiro, così si chiamava, finché era stata scoperta dai genitori e costretta
a prendere i voti in convento.
Vladimiro le aveva promesso che
l’avrebbe aspettata tutta la vita e che l’avrebbe pensata ogni giorno.
Suor Benedetta aveva trovato
la vocazione e proseguito la sua vita monacale. Avevano continuato a sentirsi e
Vladimiro le aveva inviato frequentemente donazioni per la sua missione con i
bambini.
Disse poi che pochi anni prima
Didi aveva inviato un grossa cifra in denaro per curare un bambino malato di
leucemia. La suora sorrise dicendo che il bambino era ora sano e felice.
Da quel momento aveva ricevuto
solo due comunicazioni scarne, l’ultima quasi due anni prima.
Concluse la storia dicendo che
il suo nome prima di prendere i voti era Beatrice.
Ero sconvolto e non riuscii a
trattenere una sottile lacrima che scivolò sul mio viso contratto.
Guardai Beatrice e le posi
quel ciondolo da cui non mi ero mai separato.
Lei lo guardò, lo strinse tra
le mani sbarrando gli occhi. Capì senza che io dicessi nulla.
Un attimo dopo ci ritrovammo
abbracciati lasciando esplodere un pianto tanto disperato e gravoso quanto
liberatorio.
La mia vita non sarebbe stata
più la stessa.